"Il bambino e il poliziotto". Irrefrenabile desiderio di paternità
Francesco Carini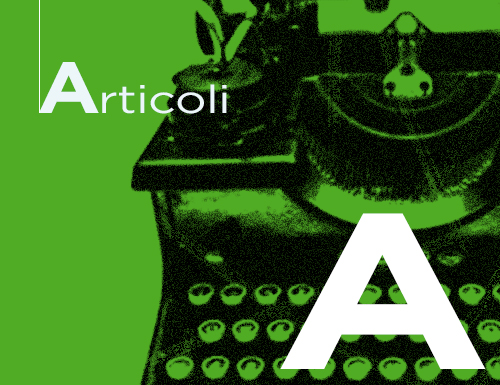
Il bambino e il poliziotto (1989) è il nono film di Carlo Verdone e il quinto nato dalla collaborazione con gli sceneggiatori Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi. Probabilmente non verrà ricordato per le scene di azione, anche perché il perno del film è l’inconscia ricerca di una famiglia da parte del commissario Carlo Vinciguerra il quale, da infiltrato durante una retata in casa della bella Rosanna Clerici, troverà e avrà l’onere di occuparsi del piccolo Giulio.
Arrestata la madre del bambino (ex eroinomane) insieme ad altri sospettati, Carlo, con il benestare del giudice minorile, ospita il bambino presso la sua abitazione fino alla scarcerazione della donna, malcelando inizialmente una voglia di paternità che si fa però sempre più forte fino a mettere in crisi la relazione segreta con Lucia, collega sposata con un altro uomo.
Questa precarietà sentimentale, acuitasi dall’arrivo di un’altra persona dalla vita burrascosa, si era già vista in Io e mia sorella (1987). E difatti è possibile compiere un’analisi comparata fra i due lungometraggi.
In Io e mia sorella è Silvia, sorella del musicista Carlo Piergentili, a portare scompiglio (dopo la morte della madre) nella noiosa routine quotidiana fra lui e la moglie Serena, finendo, dopo aver combinato un guaio dietro l’altro in giro per l’Europa, per prenderne il posto in casa nella tranquilla Spoleto insieme al figlio Zoltán, il quale alla fine lo chiamerà «papà», invece che zio. Entrambe le donne sono accomunate dal fatto di essere prive di un equilibrio, ma due bambini, da un lato Giulio e dall’altro Zoltán, le avvicinano a Carlo: Rosanna in qualità di possibile partner, Silvia (che aspetta un altro pargolo da un uomo sposato) come la figliuola prodiga che torna nell’ambiente dov’è cresciuta dopo una vita tempestosa.
D’altra parte, Verdone rappresenta in ambo i casi un uomo buono e insicuro che, attraverso l’interruzione di relazioni precarie o infelici, potrebbe colmare con un figlio acquisito il vuoto esistenziale che lo ha caratterizzato. Risulta anche interessante come i rapimenti dei due bimbi fungano da rottura nella quotidianità del protagonista, trasformandolo in eroe nel caso di Giulio e in rapitore in quello di Zoltàn, ma pur sempre con un’accezione positiva (dal momento che porta il nipote via da una specie orfanotrofio).
Il tema della famiglia è quindi molto presente nella filmografia di Verdone. Basti pensare a Il mio miglior nemico (2006), dove affetti e lavoro sfuggono letteralmente da sotto le mani di un personaggio che deve far di tutto per riconquistare la figlia, o a Sotto una buona stella (2014), in cui Federico deve ricominciare una nuova esistenza con i figli avuti dall’ex moglie dopo aver perso lavoro e partner. Proprio nel nucleo di origine o in uno nuovo, questi protagonisti spesso cercano di ripartire da zero, lasciandosi alle spalle esistenze incomplete o relazioni più o meno disastrate, trovando in una famiglia potenziale o reale il punto di origine che, in alcuni casi, potrebbe anche essere quello di arrivo.
Tornando a Il bambino e il poliziotto e a Io e mia sorella, sia Vinciguerra che Piergentili (entrambi, non a caso, “Carlo”) personificano perfettamente un ruolo più che mai attuale: quello di un possibile padre adottivo, che svolgerebbe tale funzione in modo assai più efficace rispetto a quello naturale. Se si volesse comparare la situazione descritta nei film, seppur con le enormi differenze di anni, contesto e di cultura, si potrebbe prendere in considerazione uno dei capolavori di Kore’eda Hirokazu: Father and son (2013). In quest’opera, il ricco e brillante Ryota ha cresciuto nella massima agiatezza uno dei due bambini protagonisti, facendone una sorta di “investimento”, in realtà poco redditizio per la sua mancanza di talento. Dopo aver scoperto di non esserne il padre naturale in seguito alla rivelazione di uno scambio in culla, la sua tesi appare addirittura avvalorata dalla genetica. Il suo atteggiamento per Keita fa di lui un freddo calcolatore di costi-benefici, al contrario di come si rivelerà Yudai il quale, anche se in ristrettezze economiche, continuerà ad amare indistintamente Keita e il piccolo Ryusei (figlio naturale di Ryota).
Ancor più emblematico è Un affare di famiglia (2018), sempre di Kore’eda, in cui la piccola Yuri, maltrattata dalla sua famiglia naturale, trova in un nucleo alquanto atipico – formato da gente disagiata – la tenerezza di cui ha bisogno, a dimostrazione che il legame biologico non combacia necessariamente con quello affettivo.
Dal suo lato Verdone, con i due Carlo, non solo cerca di dare un padre nel senso etimologico del termine, verosimilmente derivante dall’indoeuropeo pat (il cui significato è “nutrire”), ma spinge oltre la sua voglia di paternità riversando in Giulio e nel piccolo Zoltán un amore sincero, frutto dell’evoluzione di quelle mancanze che si portava dentro e dell’istinto naturale da essere umano, in qualche modo rievocando, in Io e mia sorella, l’incontenibile voglia di paternità che Cesare Marchetti (Marcello Mastroianni) aveva mostrato in Padri e figli di Mario Monicelli (1957).
Il 21 settembre 1974, Pier Paolo Pasolini dichiarava nel programma Rai Donna donna: «La repressione, l’oppressione, la mancanza di libertà, il conformismo, l’ipocrisia, son tutti strutturati, maturati in seno alle famiglie, perché la famiglia è nata come una piccola difesa, un po’ meschina, che fa l’uomo per difendersi dal terrore, dalla paura, dalla fame… È un meccanismo di difesa per cui l’uomo si crea una tana e nella tana fa quello che vuole: il padre opprime i figli ecc. Detto questo, la famiglia è anche il covo delle cose più belle dell’umanità. Le due cose sono orrendamente inestricabili».
In Il bambino e il poliziotto e Io e mia sorella Verdone è il rappresentante della seconda accezione di famiglia, quella positiva, perché in un possibile ruolo paterno i due Carlo vedono non il semplice capo autoritario della struttura che per Hegel costituisce la radice etica dello Stato, piuttosto il soggetto che può dare un futuro migliore a due bambini cresciuti senza la presenza di una costante figura affettiva di riferimento.
Qui sta il punto di forza di molti personaggi maschili interpretati da Verdone: la loro normalità (a volte ai limiti della mediocrità) di brave persone, spesso impacciate, in cui lo spettatore medio si può proiettare e identificare con tranquillità, vedendovi rispecchiate le proprie debolezze che, grazie al confronto con il grande schermo, non costituiscono più un difetto, ma solo tratti in comune con ruoli interpretati da un grande attore.
CAST & CREDITS
Regia: Carlo Verdone; soggetto: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Carlo Verdone; sceneggiatura: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Carlo Verdone; fotografia: Danilo Desideri; scenografia: Giovanni Natalucci; costumi: Luca Sabatelli; montaggio: Antonio Siciliano; musiche: Fabio Liberatori; interpreti: Carlo Verdone (Carlo Vinciguerra), Federico Rizzo (Giulio), Adriana Franceschi (Rosanna Clerici), Barbara Cupisti (Lucia), Luigi Petrucci (maresciallo Morra); produzione: Mario e Vittorio Cecchi Gori per Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica; origine: Italia, 1989; durata: 118’; home video: dvd CG Entertainment, Blu-ray inedito; colonna sonora: inedita.






































